



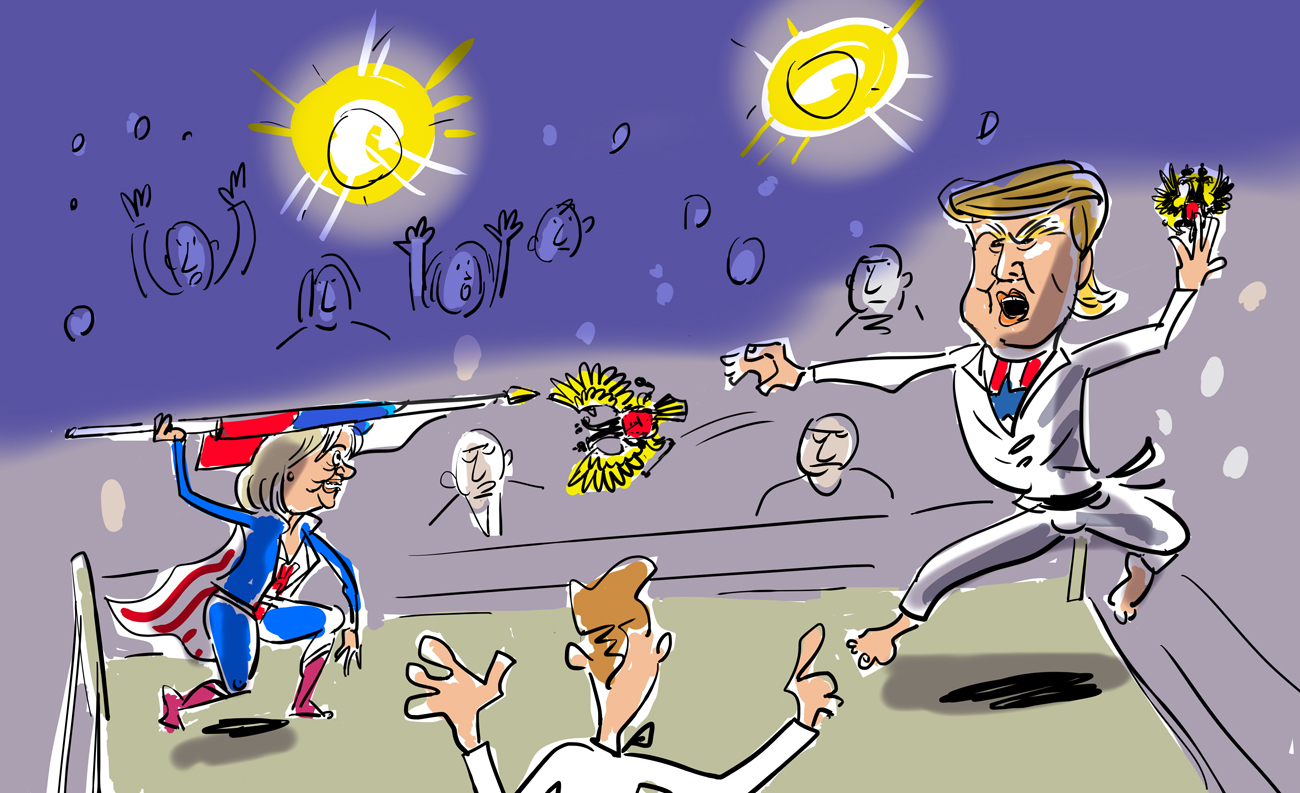
Disegno di Aleksej Iorsh
Esattamente 12 anni fa, mentre negli Usa divampava la campagna per le presidenziali, si svolgeva a New York una conferenza sulle relazioni internazionali. A contendersi il posto nello Studio ovale erano George W. Bush e John Kerry. Accadeva un anno e mezzo dopo l’invasione dell’Iraq e la maggior parte dei partecipanti alla conferenza scongiuravano gli alti vertici del Paese e l’elettorato di liberare l’America dal male di nome Bush.
Nel fervore del dibattito nella sala si alzò un rappresentante dei Paesi africani che dichiarò: “Se il futuro dell’umanità dipende così tanto dal prossimo Presidente degli Stati Uniti, allora che sia il mondo a sceglierlo”
Tale affermazione non provocò ilarità, bensì un’accesa approvazione. Bush all’epoca non era affatto popolare nell’arena internazionale e nel caso di un voto “planetario” non avrebbe avuto alcuna chance, a differenza che nel suo Paese, dove di lì a un mese sarebbe stato rieletto per altri quattro anni.
La questione così posta riflette chiaramente la percezione della realtà dopo la “guerra fredda”. Piacesse o meno, il candidato che si fosse aggiudicato la vittoria nelle elezioni sarebbe diventato inevitabilmente il leader della politica mondiale. Anche oggi in tutti i Paesi si sta seguendo con il fiato sospeso la campagna elettorale americana. Per la prima volta nell’ultimo quarto di secolo i due competitor hanno visioni radicalmente diverse sul ruolo che deve rivestire l’America nella scena internazionale.
Intanto l’assioma della leadership globale degli Stati Uniti è stato messo in discussione da alcuni attori stranieri, che lo considerano uno dei prezzi pagati per il processo di diffusione della democrazia avviato un quarto di secolo fa. La comparsa in Occidente di svariati ceti sociali che non comprendono perché si debbano investire tanti sforzi all’esterno del Paese quando esistono tanti problemi interni, ha sovvertito i fondamenti di quell’assioma. Perciò l’attuale campagna presidenziale appare anomala. Da un lato si rivolge naturalmente agli elettori interni, ma dall’altro è indirizzata anche a un pubblico esterno che si vuole convincere del fatto che l’America non rinuncerà alla leadership globale. In realtà non è affatto chiaro come questo ruolo si concretizzerà in seguito.Questa settimana è esplosa una bizzarra polemica a distanza tra Barack Obama, che è intervenuto con la sua relazione finale all’Assemblea Generale dell’Onu, e l’ex segretario generale della Nato Anders Fogh Rasmussen che ha pubblicato un articolo sul Wall Street Journal.
Quello all’Onu è stato un intervento in linea con lo stile di Obama, che ha sottolineato il ruolo assai peculiare del suo Paese, elencando tutto ciò che di positivo ha compiuto per l’umanità, ma anche gli errori ripetutamente commessi. Come a dire, non siamo onnipotenti, il sistema unipolare non è la norma, bensì un’eccezione, e qualche volta abbiamo sbagliato. Il dualismo, l’intenzione di un approccio ponderato dimostrano come Obama meglio di altri suoi compatrioti appaia consapevole della multidimensionalità del mondo contemporaneo.
Tuttavia, ciò che appare meritorio a un accademico di rado è vantaggioso per un politico.
Obama, che fin dagli inizi ha incarnato l’idea di una nuova era, cerca continuamente di abbassare il livello delle aspettative, proprio mentre da lui ci si attendono fermezza ed esiti certi. Alla fine lascia tutti scontenti, non solo gli avversari, che accusano l’assennato capo di Stato di debolezza e ambiguità, ma anche i suoi sostenitori convinti che abbia fatto troppo poco.
Al contrario, per Rasmussen, come per ogni esponente neoconservatore, è tutto chiaro: le minacce si moltiplicano, i terroristi rialzano la testa, la Russia ha un atteggiamento arrogante, la Cina si misura col potere globale, qualcuno deve porre fine a questo stato di cose.
“Il mondo ha bisogno di un poliziotto affinché la libertà e la prosperità possano prevalere sulle forze dell’oppressione e l’unico candidato affidabile e auspicabile, in grado di assumere questo ruolo, sono gli Stati Uniti”. Il politico danese esorta gli Stati Uniti a svegliarsi. Non vale la pena analizzare in profondità l’articolo: è un messaggio di propaganda rivolto all’elettorato.
Tuttavia, non ci si può esimere dal commentare che tra i problemi che esigono l’intervento dell’America per ristabilire l’ordine e spegnere l’incendio (“occorre un pompiere per spegnere le fiamme del conflitto”) si menzioni il fatto che “In Nordafrica la Libia è collassata ed è diventata un terreno fertile per il terrorismo”. Non so chi abbia avuto l’idea di suggerire all’ex segretario generale della Nato di portare proprio questo esempio, ma nel contesto dell’“incendio” che devasta realmente la Libia, la dichiarazione appare di un estremo cinismo.Le posizioni di Obama e Rasmussen concordano su un punto: non si può accettare che in America prevalga la tendenza isolazionista. Di conseguenza entrambi fanno campagna a favore di Hillary Clinton. A dire il vero, Obama parlando di persone che hanno perso la fiducia nel futuro cerca di rivolgersi agli elettori potenziali di Trump, dando loro a intendere che l’establishment comprende le loro ansie. La grancassa continua di Rasmussen si rivolge a chi è già persuaso delle proprie posizioni, ma che, probabilmente, ha ancora bisogno di consolidare le proprie convinzioni. Benché, forse, questo potrebbe voler dire che la questione è più seria e che lo spostamento del paradigma socio-politico oggi in atto, sia in America che nel resto del mondo, dimostri una futura frantumazione della classe dirigente.
È assai probabile che si stia enfatizzando l’importanza epocale delle prossime elezioni americane. Chiunque sia il vincitore, l’esito non sarà la distruzione del sistema. Hillary non potrà fare ritorno agli agognati anni '90, né Trump ai suoi amati anni '50.
L’inerzia della macchina statale è immensa, malgrado il suo disorientamento dinanzi all’imprevedibile reazione delle masse. Tuttavia, il passaggio graduale a una fase di cambiamento è inevitabile. Ha avuto inizio con Obama, che ha cercato di combinare gli slogan tradizionali con una politica di stampo diverso, e proseguirà con il futuro Presidente, acquisendo una forma nuova negli anni 2020. Sempre, naturalmente, che il successore di Obama non voglia strafare per dimostrare a Rasmussen che l’America ha smesso di dormire.
Fedor Lukyanov, è direttore del giornale Russia in Global Affairs e ricercatore presso l’Alta Scuola di Economia di Mosca
Qui la versione originale dell'articolo
Ti potrebbero interessare anche:
L'Unione Europea e quell'idea di un esercito proprio
Con l’Europa per una nuova collaborazione
Gorbachev, ansie di un mondo globalizzato
Tutti i diritti riservati da Rossiyskaya Gazeta
Iscriviti
alla nostra newsletter!
Ricevi il meglio delle nostre storie ogni settimana direttamente sulla tua email